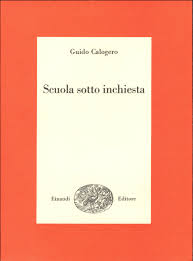Guido Calogero (Roma 1904-1986) è stato professore di filosofia, saggista e politico italiano. Nel 1925 si laurea in filosofia alla Sapienza di Roma; nel 1931 come professore universitario presta giuramento al partito fascista. Ma le sue idee politiche sono antifasciste. E’ tra i principali esponenti insieme a Aldo Capitini del liberalsocialismo e nel 1942 è tra i fondatori del Partito d’Azione, che riunisce le due aree antifasciste non comuniste di Giustizia e Libertà e del liberalsocialismo. Nel 1942 è arrestato e confinato in Abruzzo, perde la cattedra universitaria. Dopo la fine del fascismo e della guerra continua il suo impegno politico, nel 1955 è tra i fondatori del Partito Radicale. Muore a Roma nel 1986.
Sorgente: Guido Calogero – Wikiradio del 17/04/2017
Di seguito riportiamo un estratto da Scuola sotto inchiesta, raccolta degli interventi di Calogero sulla scuola italiana.
Io sono stato scolaro di ginnasio a Pisa e di liceo a Roma, al “Mamiani”; poi ho insegnato per due anni storia e filosofia al “Tasso”. Mi sia permesso parlare anzitutto di quest’ultima esperienza. Nei primi tempi, essa fu spiacevolissima. Finché si trattava di spiegare qualche problema ai giovani, di leggere un testo, di commentare un libro di storia, la cosa non presentava difficoltà. Bastava aver qualcosa da dire, e i ragazzi stavano a sentire, e si interessavano. Ma, disgraziatamente, questo si poteva fare soltanto per meno di metà dell’ora. Per il resto del tempo, bisognava interrogare: altrimenti come si sarebbero potuti assegnare trenta o quaranta voti Mentre il ragazzo chiamato alla cattedra subiva l’interrogatorio, tutti gli altri non avevano niente da fare, e per cacciare la noia tentavano ragionevolmente di fare conversazione tra loro. Il che, d’altra parte, non era tollerabile, perché, chiacchierando loro, come avrei potuto capire io quel che diceva l’interrogato? Nemmeno, poi, era ammissibile che essi facessero per loro conto altre cose ragionevoli, come per esempio leggere il giornale, o studiare altri libri, o scrivere diari personali, o inviare messaggi alle compagne; perché da tale loro indipendente attività sarebbe risultato evidente che il professore non lavorava in tutto quel periodo per altro scopo che quello di assegnare un voto ad uno solo degli studenti della classe. Non restava quindi che ottenere il loro silenzio mercè un’intimidazione disciplinare. E ciò non presentava speciali difficoltà; ma ne risultavano alcune conseguenze, che purtroppo mi apparivano allora come le inevitabili calamità di ogni insegnamento medio.
In primo luogo, all’attenzione conquistata mercè l’interesse si sostituiva il silenzio ottenuto attraverso la paura della sanzione. Non c’era più la confidenza, la naturalezza, la cordialità: c’era la disciplina. In secondo luogo, la buona condotta veniva ad identificarsi con lo stare zitti. La più comune esortazione disciplinare, che uscisse dalle labbra del professore, era la parola “silenzio”. Che poi, durante la vita, il tacere potesse costituire in date circostanze una condotta non meno deplorevole che il parlare in altre, non aveva nessuna importanza. Nella scuola aveva dieci in condotta solo chi stava assolutamente zitto, o tutt’al più parlava solo quando fosse stato interrogato, secondo l’immortale regola di condotta dei poliziotti maleducati e dei burocrati autoritari.
Eppure, ripeto, tutto questo mi sembrava allora un male inevitabile, una delle tante cose che rendevano la scuola media di necessità odiosa tanto a chi vi studiasse quanto a chi vi insegnasse, cosicché sia gli uni che gli altri cercavano poi di fuggirne il più presto possibile. Scoprii bensì una volta, durante gli scrutini, che un mio collega seguiva il sistema di dare nei primi due trimestri indiscriminatamente il sei a tutti li scolari, rinviando ogni interrogazione e differenziazione alla fine dell’anno. Ma questo mio collega era non soltanto molto intelligente, ma anche alquanto bizzarro; e io dubitavo, a ora, che dipendesse soltanto da tale sua bizzarria l’adozione di un metodo il quale mi pareva irrispettoso sia del dovere di giudicare sia del diritto di essere giudicati. Ero stato abituato, da ragazzo, a riferire tutti i giorni a casa se e quali voti avevo avuto, e un insegnante che non differenziasse i suoi scolari coi voti mi sembrava quindi che mancasse al suo compito professionale. Naturalmente, vedevo anche allora che la cosa non andava, che ogni disco fra professori e scolari era falsato dall’aspettativa del voto e la limpidezza dell’atmosfera scolastica risultava velata alla nebbia giudiziaria delle interrogazioni e delle votazioni. Ma mi avevano insegnato che il dolore nobilita l’uomo, che questo mondo è una valle di lacrime, che solo attraverso la sofferenza si educa lo spirito; e quindi mi sembrava da accettare anche che la scuola fosse un fatto eminentemente spiacevole tanto per gli insegnanti quanto per gli scolari.
Da scolaro, del resto, non avevo avuto anch’io la stessa esperienza? Ero stato alunno di un ottimo liceo romano, con professori che certo non potevano dirsi, nel complesso, inferiori alla media. Ma al secondo anno ne ero già così esasperato che sgobbai ferocemente tutta l’estate, per passare a ottobre all’università senza subirne ancora un terzo. Mi salvai dalla nevrastenia, ma ne uscii miope. Di fatto, le più belle ore che io ricordo del liceo sono quelle che trascorrevamo quando, asserragliati con Enzo Sereni nell’ultimo banco della classe, ci disinteressavamo di quel che succedeva e leggevamo o scrivevamo f cose nostre. Erano, appunto, gli interminabili periodi delle interrogazioni: e noi rimediavamo occupandoci d’altro. Qualche volta, si capisce, venivamo improvvisamente disturbati dal professore, il quale ci chiedeva a bruciapelo che cosa avesse domandato al ragazzo che stava interrogando: né avevamo il coraggio di rispondergli che non eravamo noi ad essere distratti, ma piuttosto lui che ci stava distraendo. Ciò non toglie che, qualche volta, il professore d 1 greco e di latino, si mettesse lui a leggere Omero: e, allora, naturalmente, stavamo subito a sentirlo, e lo seguivamo sul testo, perché chi non resta incantato se uno gli traduce l’Odissea? La cosa ci sembrava, bensì, stranamente anormale, come se in quel caso il professore, forse animato da previe libazioni e dimentico del preside e del ministro, trascurasse temporaneamente il fatto che a tradurre Omero dovevamo sudare noi: altrimenti, se egli Omero ce lo rendeva piacevole, che cosa mai diventava la scuola, un divertimento? E come si sarebbe potuto, allora, desiderare di far vacanza, invece che di andare a scuola? D’altra parte, se il professore, in luogo di interrogare, avesse speso la maggior parte del tempo a leggerci appunto lui i classici, e a farceli godere così come noi godevamo le belle giornate quando andavamo in bicicletta e il bel mare quando ci nuotavamo dentro, allora che bisogno ci sarebbe stato di studiare a casa? Probabilmente avremmo imparato più e meglio semplicemente stando a scuola, senza quasi dover riaprire i libri negli intervalli fra una lezione e l’altra; e tutto il tempo libero, a casa, avremmo potuto adoperarlo leggendo o scrivendo o facendo quel che ci avesse interessato di più, e che per ciò stesso ci avrebbe educato di più. Evidentemente, sarebbe stato troppo bello. E non era possibile, perché dove avrebbe poi trovato il tempo, il professore, per le interrogazioni?
La stessa cosa si sarebbe potuta dire a proposito dei rarissimi casi in cui una lezione si trasformava in una discussione. (Per la verità, a me sembra di ricordare che ciò accadesse solo una volta, credo in occasione della venuta di un giovane supplente). Avevamo la vaga sensazione che, se invece di sentirci dire che Talete aveva visto il principio di tutte le cose nell’acqua e Anassimene nell’aria, e Socrate aveva scoperto il concetto e Kant la sintesi a priori, e di ristudiare tutto ciò a memoria a casa per ripeterlo il giorno dopo in caso di interrogazione e poi dimenticarlo dopo alcuni giorni e poi ristudiarlo nell’imminenza dell’esame di maturità e poi ridimenticarlo una buona volta per sempre – se insomma, invece di sobbarcarci a questa infinita noia di ricordare e dimenticare e ricordare e dimenticare cose egualmente prive di interesse tanto se ricordate quanto se dimenticate, noi avessimo domandato al professore di filosofia se aveva paura di morire e perché voleva bene a sua moglie e quale criterio di condotta pensava che si dovesse seguire nella vita ed in base a quale principio diceva che quel film era più bello dell’altro, e sulle sue risposte avessimo impiantato un dibattito e ci avessimo tirato dentro tutta la classe e volta per volta avessimo cercato di approfondire quanto era risultato dalla discussione precedente, magari non facendo altro tra lezione e lezione che ripensare un poco a quanto avremmo voluto sostenere nella discussione futura… – avevamo la vaga sensazione, dico, che, se l’ora di filosofia fosse trascorsa in quel modo, ne avremmo tratto assai più vantaggio, per il nostro allenamento a riflettere con maggior attenzione e coerenza sui più importanti aspetti del nostro modo di veder le cose, che da ogni altro studio mnemonico di paragrafi di manuali. E le pagine dei classici ci sarebbero venute incontro come risposte a domande, richieste dalla discussione medesima. II professore stesso, del resto, avrebbe ben finito per accorgersi, attraverso le lunghe ore delle discussioni, delle nostre diverse qualità intellettuali, di prontezza e di penetrazione e di attenzione ai problemi: cosicché avrebbe potuto anche stabilire, volendo, votazioni e graduatorie. Non avrebbe potuto però dare sette a Caio, perché, studiata la lezione, aveva attribuito la haecceitas a Duns Scoto, e quattro a Tizio che l’aveva attribuita a Scoto Eriugena… Qui dunque cascava l’asino: il sogno era troppo bello, le discussioni potevano farsi solo quando venivano i supplenti, o l’insegnante di religione che non aveva il diritto di dare il voto. I professori seri non si lasciavano sedurre dalla baraonda dei dibattiti: con loro bisognava studiare esattamente quel che bisognava ripetere per l’interrogazione, e solo dopo quest’ultima si poteva stare in pace per un po’ di tempo.
Diranno, i miei lettori adulti, che sono stato molto disgraziato nelle mie esperienze scolastiche? Può darsi; ed effettivamente credo che parecchi insegnanti tentino sempre più di allontanarsi da quell’antiquato modello didattico. Ma credo anche che, purtroppo, esso sia ancora largamente in atto. E soprattutto temo che capiti a molti quel che è capitato a me come a mio figlio, cioè di accorgersi che certi infelici metodi didattici non sono inevitabili, solo dopo aver scoperto che in altri ambienti le cose vanno benissimo, anzi vanno meglio, senza di essi. Il conservatorismo educativo è probabilmente il più pericoloso di tutti i conservatorismi, perché a nessuno piace ammettere che i suoi maestri avrebbero potuto educarlo meglio. Riformare le altre cose, sta bene: ma riformare il modo in cui siamo stati fatti noi stessi, chi ne ha il coraggio? Non parliamo poi di quel che succede quando il parere sulle riforme educative viene richiesto, a titolo di referendum, alla grande massa degli stessi educatori. Come si può pretendere che, nell’insieme, pensino che quanto fanno non sia fatto bene? Se se ne accorgessero, comincerebbero a mutarlo da loro stessi. Niente è più facile, in fondo, che tradurre una scuola giudiziaria in una scuola di libera e umana conversazione tra maestri e allievi, quando davvero lo si voglia (nel peggiore dei casi, si può farlo almeno nei primi due trimestri, col sistema di quel mio collega… ). Ma ciò presuppone, appunto, l’avere a un certo punto capito che la scuola non deve essere giudiziaria, o deve esserlo il meno possibile, quando già lo sono, purtroppo gli inevitabili esami: e ciò è tutt’altro che facile in ambienti in cui per vecchia tradizione è giudiziario tutto, non solo nell’aldiquà ma perfino nell’aldilà. Credo che in nessun paese del mondo si legga tanto Rousseau quanto in Italia (forse nemmeno in Francia o in Svizzera): ma chi poi crede, da noi, al valore positivo, creativo, della libera spontaneità del fanciullo? Anche i laici più inveterati, in Italia, credono al peccato originale. Il ragazzo è originariamente sbagliato storto e deve essere fatto soffrire durante tutta la fanciullezza e l’adolescenza, per diventare adulto. Egli vorrebbe divertirsi. No, deve sgobbare (quando si potrebbe studiare il modo di farlo lavorare in modo divertente). Egli vorrebbe leggere libri piacevoli. No, deve leggere libri noiosi (noiosi, beninteso, anche per l’insegnante, quando ce ne sarebbero tanti che potrebbero nello stesso tempo divertire lui e loro). Egli vorrebbe sentir parlare di problemi che lo interessano. No, deve sentire parlare di problemi che interessano i suoi maestri (o che i programmi del ministero presuppongono che interessino i suoi maestri, i quali poi troverebbero forse più interessanti i problemi suoi). Si sono fatte tante prediche filosofiche, in Italia, sull’autonomia dell’educando: ma dov’è poi la scuola che gli lasci una qualsiasi libertà di educarsi? Quale scuola gli permette di disinteressarsi della matematica, se gli interessa il latino, o di disinteressarsi del latino, se gli interessa la matematica? No, deve studiare in ogni caso tanto il latino quanto la matematica, perché l’uno e l’altro gli quadreranno la testa, e lo educheranno a ragionare, specialmente attraverso la cosiddetta analisi logica, scienza la quale gli insegna adire qualsiasi insulsaggine purché in essa il soggetto sia messo al nominativo. Soprattutto, poi, deve fare per tutta la vita scolastica un esercizio di fondamentale importanza. Quel che é detto da un tema in tre righe, ridirlo in tre pagine: quando, se mai un esercizio ci fosse da fare in Italia, paese dove gli interventi in Parlamento durano in media un’ora laddove in altri paesi di meglio funzionante democrazia durano in media cinque minuti, dovrebbe proprio consistere nel prendere i testi di quei discorsi di un’ora e riscriverli in modo da far loro dire più o meno le stesse cose in cinque minuti (cosa che, del resto, si fa appunto in quei paesi, e così si impara fin da ragazzi a disciplinare la propria eloquenza).
D’altra parte, quando è riuscito a scappare dal liceo, non si illuda lo studente italiano di esser lasciato libero all’università. Anche lì, se vuole dedicarsi al latino, deve studiare la geografia, e, se vuole dedicarsi alla geografia, deve studiare il latino. Anzi, qualunque materia gli interessi, deve studiarne almeno un’altra ventina, e non già soltanto quelle che naturalmente studierebbe da sé per approfondire la prima: tutte male, s’intende (perché chi mai può interessarsi di tante cose, a questo mondo?), e quindi con profondo odio, esasperazione, e coltivazione di nevrosi. Ma come si potrebbe permettere che egli facesse il proprio comodo dedicandosi soltanto ad approfondire le materie che ama? L’università non è il giardino dell’amore: gli studenti non debbono amare ne le ragazze, né le materie; ameranno poi, dopo superato l’esame di abilitazione (non ha detto forse il Manzoni che di amore ce n’è anche troppo nel mondo?). Un po’ di odio fa bene: essere costretti a fare quel che si odia è il miglior tonico della moralità. E non si tirino fuori quegli altri paesi, di tradizione lassistica o americanoide, dove non solo all’università ma anche nella scuola media i ragazzi hanno un largo ambito di scelta per dedicarsi alle materie che più desiderano di approfondire. Non si venga a dire che l’Inghilterra recluta i suoi civil servants, i funzionari direttivi della sua burocrazia statale, in base a esami di concorso imperniati sull’argomento a cui il candidato si è dedicato specificamente durante tutti gli anni di quella che nelle loro università corrisponde alla nostra facoltà di Lettere (cosicché, per esempio, uno può entrare nei ministeri dopo aver dimostrato che per quattro anni ha studiato bene latino, greco e storia antica, mentre in Italia deve dimostrare di aver studiato male venti materie differenti). Non si vengano a citare questi esempi, perché si sa benissimo che i paesi anglosassoni sono materialisti e decadenti, e l’Inghilterra ha perduto l’India, mentre l’Italia conquistò l’Etiopia; d’altra parte, come si può confondere la tradizione storica italiana con quella inglese? Può farlo solo chi pretenda che degli Italiani ci si possa fidare come degli Svizzeri e degli Inglesi e degli Scandinavi, quando ogni banchiere milanese che sia stato nella City vi può spiegare che per versare denaro in un conto corrente della Banca Commerciale ci vuole inchiostro, carta, lavoro e tempo almeno tripli che quelli richiesti da un’analoga Operazione nelle banche inglesi, appunto perché queste sono fondate sul presupposto che degli uomini in genere ci si può fidare e conviene accettare la percentuale di rischio della truffa, mentre le banche italiane, costruite sul modello tedesco, partono invece dall’idea che l’uomo è essenzialmente un imbroglione, cosicché ognuno deve essere anzitutto armato di carta penna e calamaio e pezze d’appoggio contro ogni altro, anche se questo aggrava il bilancio dell’insieme assai più di quanto lo aggraverebbe la media prevedibile delle truffe. Noi non possiamo, da buoni Italiani, dimenticare la nostra tradizione nazionale e storica, che è quella di ritenerci ladri, imbroglioni, corruttori ed evasori fiscali; e così neppure possiamo abbandonare la nostra tradizione scolastica, che è quella di non mai fidarci di chi ha studiato a lungo e con passione le poche cose che veramente lo interessano, e quindi di pretendere invece che ne studi male e di mala voglia molte, purché i controlli in proposito siano ancora di più… purché per un terzo del tempo si studi e per due terzi del tempo si interroghi.
Sto esagerando? Magari fosse. Ma certo sto dirottando nel mare magnum dei problemi della riforma scolastica italiana; e bisognerà bene che mi fermi, perché per questi ci vorrebbe altro che un articolo. La scuola italiana è talmente antiquata in tanti suoi aspetti che non si può pretendere di correggerli tutti rapidamente; ma appunto perciò può essere opportuno cominciare a isolare almeno questi punti, in cui è possibile agire senza soldi, senza sconquassi, senza maggior fatica per nessuno, e probabilmente con maggior soddisfazione per tutti. Sono lieto che mio figlio abbia indicato uno di questi punti, e per mio conto dichiaro che sono senz’altro d’accordo con lui. La scuola italiana, in generale, dovrà essere resa assai meno faticosa, meno autoritaria, meno estranea e angosciosa, e quindi meno creatrice di nevrosi, di quanto ora sia. Ma, intanto, togliamo da essa quella spada di Damocle continuamente sospesa sul capo dei ragazzi, che è il sistema delle interrogazioni. Proprio perché gli esami sono necessari, cerchiamo di farli il più seriamente possibile: e le cose serie e importanti non posso accadere tutti i giorni. Un esame scritto alla fine di ogni trimestre, fatto col sistema dei questionari e con larga possibilità di scelta dei quesiti a cui rispondere, può adattarsi a tutte le necessità didattiche. Per tutto il resto del tempo, i professori siano liberi di leggere testi con gli scolari, di esercitarvisi con loro, di rispondere alle loro interrogazioni, di inventare temi di studio e di ricerca, e, soprattutto di conversare e di discutere, senza troppa paura se le discussioni non saranno rapidamente concludenti e se nella classe non .regnerà quel silenzio, in cui si sentono ronzare le mosche (ronzio che è la voce della disciplina e della noia, anche quando le mosche sono state uccise dal Ddt). La civiltà della convivenza, a cui tutti, in un modo o nell’altro, cerchiamo di educarci, non sta né nel clamore, né nel silenzio, ma nell’ordinato colloquio, che è equidistante da entrambi. Purtroppo la nostra scuola è ancora troppo rispondente a quella fase arcaica, sacerdotale, fascista, dello sviluppo della civiltà in cui per domare il clamore si crea soltanto il silenzio… il quale allora si può rompere solo quando si sia interrogati!
Non credo di essere troppo malato del mio solito ottimismo se penso che l’enorme maggioranza dei docenti e degli scolari italiani non può non accorgersi che una scuola senza interrogazioni diventa immediatamente meno faticosa, meno noiosa, meno ossessionante, insomma più piacevole e positiva tanto per gli uni quanto per gli altri. Io sono convinto che essa abolirebbe in gran parte la necessità del lavoro a casa, e quindi contribuirebbe in larga misura all’alleggerimento del carico scolastico che in Italia è eccessivo, e permetterebbe di tener conto del fatto che i giovani non debbono educare soltanto la loro testa, ma anche le loro gambe (vero è che da noi si tende a credere che le gambe le abbiano soltanto le ragazze, e che perciò esse vadano considerate il meno possibile: il corpo è un fatto eminentemente femminile, peccaminoso e censurabile; mio figlio, spero solo per mancanza di palestra, ha superato l’esame di ginnastica oralmente, il che non significa che gli abbiano fatto fare esercizi con la bocca, ma bensì che gli hanno chiesto di dire in che cosa consistono certi movimenti ginnastici…). L’ideale sarebbe quello di imparare a scuola quanto si ritiene debba insegnare la scuola, e non già di impararlo a casa per ripeterlo a scuola mentre gli altri si annoiano. Né ci si dovrebbe mai preparare a nessun esame. Non si dovrebbe conoscere in anticipo il giorno in cui si sosterrà l’esame. Per tutta la nostra vita di adulti, noi non facciamo che sostenere esami, a cui non abbiamo il tempo di prepararci: quel che conta, in ogni caso, è quel che abbiamo acquisito, quel che è rimasto in noi, quel che è diventato nostro. Non possiamo andarlo a ripassare sulle dispense.
Ma, già, mi dimenticavo che la scuola italiana è profondamente psicanalitica, è freudiana da secoli, anche se continua ad avere una tremenda paura della psicanalisi. Essa infatti presuppone che importi moltissimo imparare a memoria certe nozioni il giorno prima dell’esame, nonostante che esse vengano dimenticate il giorno dopo. Io, per esempio, credo di aver saputo, per qualche giorno, in che anno morì Traiano Boccalini. Ora non lo so più, naturalmente, e mi rifiuto assolutamente di saperlo (mi basta sapere che è morto, anzi, per verità non mi interessa neppure di sapere se è morto o vivo). Ma quella data, evidentemente, esercita ancora sul subcosciente una profonda influenza sulla mia cultura.
D’altra parte, che c’entrano gli esami che si sostengono nella vita con quelli che si sostengono a scuola? Paragonare gli uni agli altri presuppone il vieto concetto, pragmatistico e utilitaristico, che la scuola serva alla vita. Mi si permetta per l’ultima volta di citare mio figlio. Gli ho chiesto qualche tempo fa: – Non ti pare che, procedendo così le cose, voi finirete con l’imparare molto più dalla radio, dal teatro, dalle vostre discussioni politiche e sportive e di ogni genere, che da quanto studiate per la scuola? – Fino ad un certo punto papà, – mi ha risposto: – perché quanto studiamo per la scuola è in gran parte così estraneo alla vita e alla realtà di tutti i giorni, che, se non ce lo facessero studiare là, dove mai l’impareremmo?